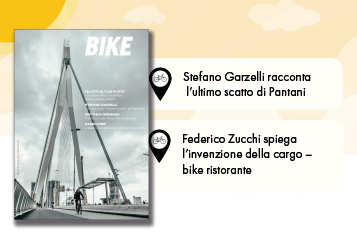Dentro la Parigi-Roubaix, la corsa che non si vede
C’è chi insegue la gloria, chi insegue un anello, chi invece uno scatto e chi ancora un altro attimo da imprimere nei propri occhi. Alla Parigi-Roubaix, una delle cinque classiche Monumento in calendario (e, per qualcuno, anche la più dura di tutte), tutti inseguono qualcosa e, più che in televisione, ce ne si rende conto dal vivo percependo in maniera tangibile, sia dal punto di vista visivo che sonoro, quanto queste rincorse si svolgano in un clima convulso e a dir poco caotico.
In primis, ci sono i corridori, i protagonisti di questo peregrinare infernale fra le strade acciottolate del dipartimento del Nord. Su questi sentieri di pietre a schiena d’asino che, a seconda dei casi, possono vibrare al passaggio della carovana (Orchies) o far scoppiare penumatici con botti in stile Capodanno (Foresta di Arenberg), ragazzi e ragazze inseguono un successo che può valere o sublimare una carriera sfidando un susseguirsi sfiancante di vibrazioni, buche e tratti esposti al vento che, chilometro dopo chilometro, succhia lucidità ed energie. Solo chi, con esperienza o sfruttando una giornata di grazia, riesce a conservarle più a lungo ha la meglio. Per tutti gli altri, e lo si comprende leggendo le smorfie e l’incedere sofferente di chi transita lontano dai primi, l’obiettivo di giornata assume i connotati e la forma ovale del velodromo André-Pétrieux: arrivare lì, in quello che è uno dei luoghi simbolo del ciclismo, è l’unica motivazione che spinge uomini e donne a continuare a pedalare imperterriti anche con distacchi superiori al quarto d’ora, l’unica ricompensa (al pari delle docce presenti al suo interno) in grado di ripagare degnamente l’insensata fatica fatta nei chilometri precedenti.
C’è poi chi, dietro ai corridori, è chiamato per lavoro a star dietro più possibile. È il caso dei fotografi che devono cercare di immortalarli più a lungo e quante più volte riescono, un compito questo che li porta, assieme ai motociclisti che li accompagnano in corsa, ad un marcamento schizofrenico fatto di continue scorciatoie per le campagne e di fulminei “stop and go”. Ne è prova, ad esempio, ciò che accade tra i due settori in pavé a Bourghelles, quelli di Cysoing à Bourghelles e Bourghelles à Wannehain, collegati da una lingua in asfalto, non percorsa dai ciclisti, di qualche centinaio di metri. Lì, una volta passata la testa della corsa sul primo, i fotografi montano immediatamente in sella alle moto, bardati con l’immancabile scaldacollo (accessorio fondamentale per filtrare la polvere che perennemente li circonda nei giorni di sole), per “volare” sul secondo e quindi, transitati nuovamente gli atleti, muoversi allo stesso modo alla volta di quelli seguenti. Il lavoro finale che poi possiamo ammirare nelle ore successive sui siti e sui giornali è, dunque, il risultato di una corsa nella corsa altrettanto provante di cui forse non molti sono al corrente ma che, come quella di chi disputa Roubaix in bici, va parimenti rimarcata e applaudita.
Attorno ai corridori, vi sono infine i tifosi che, come squame colorate, vanno di volta in volta a comporre e disfare ai bordi della strada due chiassosi ed esaltati serpentoni. Affamati di ciclismo e d’azione, questi accompagnano la marcia dei propri beniamini secondo un meccanismo che li vede compattarsi al passaggio dei ciclisti in un settore di pavé, disgregarsi negli istanti immediatamente successivi il loro transito e poi riunirsi, come per magia, in un altro punto più avanti. In realtà, come nel caso dei fotografi, tale incessante inseguimento è il frutto di un attento studio del percorso, delle strade alternative per raggiungere i vari spot, delle medie orarie della corsa e delle tempistiche di spostamento tra una location e l’altra. Un lavoro ingegneristico o quasi insomma che però, se ben fatto, può appunto regalare la soddisfazione di ammirare i corridori ed essere nel vivo della corsa più volte, passando per luoghi che hanno fatto la storia di questo sport. Si può allora, come fanno in molti, vivere lentamente l’attesa tra un libro, qualche birra, una partita a carte o un barbecue casereccio nella Foresta di Arenberg, vedere i corridori destreggiarsi sulle infime pietre di quel tratto e poi catapultarsi al Carrefour de l’Arbre, settore spesso decisivo e anche quello, per via della sua durezza ma anche per la presenza del megaschermo, degli stand di alcuni sponsor e del ristorante omonimo, densamente popolato il fatidico giorno. Nel mezzo, in questi veloci spostamenti, può capitare, altra magia della Roubaix, di incontrare gente che non ha mai visto una corsa di ciclismo in vita sua, di ritrovarsi assieme ad altri devoti a toccare con fare religioso le pietre come a cercar conferma della loro reale consistenza, di scorgere letteralmente la corsa passare sopra la propria testa su alcuni dei tanti cavalcavia della zona, oppure di vederla scorrere al proprio fianco percorrendo l’autostrada dove non è raro che qualcuno addirittura si fermi preso dal richiamo all’evento.
È tutta così la Roubaix, un muoversi smanioso a caccia di qualcosa, una corsa di sorprese, ripartenze da fermo (o quasi) di accelerazioni, una classica con una sua sacralità animata da una frenesia che ti rapisce, ti ingloba e ti riempie di polvere in ogni dove di cui capisci l’incanto solo quando, una volta concluso il tutto, finalmente riesci a fermarti e a rimettere in ordine i pensieri. È in quelle circostanze che gli interrogativi, sepolti in precedenza dagli echi dei sobbalzi e delle vibrazioni, vengono a galla: “Perché tutto questo? Perché questa gara? Qual è il senso di tutto ciò? Perché impazzire in questo marasma?”. Le domande però, per quanto ci si sforzi, restano senza risposte sensate perché qualsivoglia tipo di ragionamento razionale, passando in rassegna quanto vissuto, viene messo a tacere da una conclusione di pancia, più semplice e sintetica, che emerge in maniera prepotente e che alla fine mette d’accordo tutti: “Che figata l’Inferno del Nord”.
(Photo credits: A.S.O./Pauline Ballet)